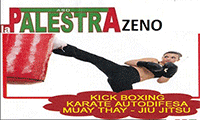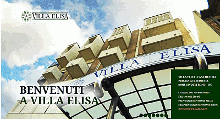Reggio, incontro sull’ incendio della casa del popolo di Trieste del 1920
Cento anni fa, esattamente il 13 luglio del 1920, a Trieste veniva dato alle fiamme il Narodni dom (in sloveno, Casa del popolo o Casa nazionale) un edificio polifunzionale, punto di riferimento della comunità slovena della Città, nel quale trovavano posto anche un teatro, la banca che aveva finanziato la costruzione dell’edificio, un caffè e l’Hotel Balkan. Si trattò, secondo alcuni storici, per la gravità dell’episodio, di una sorta di anticipo sinistro di quello che sarà più tardi, con conseguenze molto più gravi, nel 1938, in Germania “la notte dei cristalli” (Kristallnacht) durante la quale furono date alle fiamme sinagoghe, negozi ed edifici riconducibili alla comunità ebraica tedesca. L’episodio tedesco è stato senza dubbio più grave avendo riguardato una intera nazione ma i prodromi di esso con l’uso delle fiamme ha nel Narodni Dom un precedente che contribuì a spezzare ogni sia pur tenue legame tra gli italiani e le comunità slovena e croata, creando quel clima di odio e rancore irriducibili, anche a causa della forzata italianizzazione della Venezia-Giulia imposta dal Fascismo, che esploderà in maniera tragica nel biennio 1943-1945.
L’anniversario, al quale i mass media hanno dato ampio risalto per la visita congiunta a Trieste del Presidente Sergio Mattarella e del suo omologo sloveno Borut Pahor, nel corso della quale, tra l’altro, dopo cento anni, è stato restituito alla comunità slovena l’edificio ricostruito, è stato al centro di un incontro promosso presso lo Spazio Open dall’Associazione Culturale Anassilaos con l’intervento del Prof. Antonino Romeo, disponibile apertire da oggi sul si to facebook di Anassilaos e su You Tube.
Il relatore ha ricostruito, a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, i complessi difficili rapporti tra la comunità italiana, maggioritaria, e quella slovena, minoritaria, in una città come Trieste che, fino al 1918, era parte integrante dell’Impero Austro-Ungarico nonché unico porto dello stato asburgico. La vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale e le difficoltà incontrate dal nostro Paese nel far valere, in sede di discussioni sul trattato di pace di Versailles, il proprio punto di vista, ancorato al Patto di Londra del 1915, non riconosciuto dagli Stati Uniti, e in parte inattuabile per il crollo del duplice impero e la nascita dalle sue ceneri di nuovi stati, compresa la Jugoslavia (Croati, Sloveni e Serbi), da cui l’idea della “Vittoria mutilata” di cui scrisse D’Annunzio, non poteva che accrescere i contrasti tra Italiani e Sloveni. Qualche mese prima, d’altra parte, il 12 settembre 1919, lo stesso Gabriele D’Annunzio dava inizio all’avventura fiumana che sarebbe durata fino al dicembre del 1920 accrescendo le tensioni. Ad aggravare la situazione si aggiunse la presenza a Trieste di Francesco Giunta, divenuto segretario del Partito Fascista. I “Fasci di combattimento”, nati nel 1919, accoglievano all’inizio nel proprio seno le più diverse tendenze politiche, di destra e di sinistra, ma successivamente Mussolini diede al movimento quella caratteristica violenta che durerà fino alla conquista del potere. Francesco Giunta, alimentando con una politica aggressiva e con un linguaggio violento, il contrasto tra le comunità, in poco tempo conquistò l’egemonia politica in Città. Il “casus belli” e il pretesto per accendere le polveri fu dato dall’episodio di Spalato nel corso del quale persero la vita il Comandante della nave Puglia, Tommaso Gulli, nostro concittadino, e il motorista Aldo Rossi.
Nel comizio del 13 luglio in Piazza dell’Unità Francesco Giunta contribuì ad accendere vieppiù gli animi e alla fine del comizio gruppi fascisti si avviarono presso il Narodni Dom che venne devastato e dato alle fiamme. L’episodio di violenza registrò una sola vittima ma le conseguenze “politiche” furono gravi perché impostò, almeno fino alla fine del regime fascista (25 luglio 1943), la politica dell’Italia nei confronti delle minoranze presenti nelle zone di confine e comunque all’interno del territorio nazionale, con una politica vessatoria di ogni diversità linguistica e culturale.
Caterina Sorbara